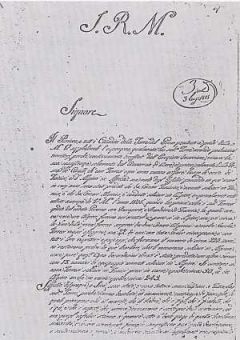|

Intarsi
di marmi policromi per riprodurre
una corallina
(particolare dell’altare
maggiore della Chiesa di S.
Maria di
Costantinopoli, Torre del Greco). Sec. XVIII
Nel ’700 i pescatori di Torre prevalevano su quelli degli altri centri
marinari (Ischia, Procida, Resina, Pozzuoli, Praiano ecc.). Nel 1747
essi dispone- vano di 400 barche con le quali, purché vi fosse corallo,
raggiungevano qualsiasi destinazione.
Erano coraggiosi e perciò andavano a pescare sui banchi della Sardegna
e della Barberia anche quando, prima del 1740, era loro vietato il
lavoro. Tutte queste doti positive, però, raramente hanno assicurato ai
corallini una vita facile e serena; anzi, essi hanno sempre dovuto
combattere contro la miseria in terra e i pericoli in mare; e di questi
il più temuto era costituito dalla cattura da parte dei Mori, anche
perché quella schiavitù durava tanti anni quanti ne impiegavano le
misere famiglie a racimolare il denaro sufficiente a pagare il riscatto
preteso. Pietro Loffredo descrive autobiograficamente le traversie dei
corallini del suo tempo:
«Il nostro povero padre Giosue, benché afflitto da diverse per- dite,
aveva a cuore la liberazione del suo figlio Tommaso; ma le finanze non
gli consentivano i capitali che per la liberazione esigeva il Bey di
Tunisi». E più avanti:
«Secondo quanto abbiamo descritto, si vede che per i 10 anni che duro
il primo Impero di Francia il nostro padre e tre miei fratelli stettero
schiavi in Algeri; e nei primi anni mori uno dei fratelli essendosi
fratturato un piede nel mentre era con gli altri lavorando e trascinando
scogli per il porto di Algeri».
E proprio da questi Mori i
pescatori di corallo e le loro famiglie hanno subito i dolori più
atroci, come quello conseguente al massacro avvenuto nel maggio 1816 a
Bona (Annaba); il padre spirituale dei pescatori torresi, don Gerardo
Palomba, scampato all’eccidio, fece un dettagliato resoconto dell’accaduto:
«Ed ecco una crudele tragedia, a chi aprivano il capo, a chi tagliavano
le braccia, le mani; a chi 1’interiora cacciarono fuori, finanche a
scannare i cristiani come porci, talmente che di 200 cristiani chiusi in
quella stretta prigione, non eravamo 30 sani, ed il sangue dei medesimi
copriva tutti i piedi». Parlando ancora della sua vita di pescatore di
corallo, il Loffredo dice:
«Chi poteva far presente le loro
sofferenze? Ignoranti e poveri rimanevano sottomessi a tanti tiranni,
per i quali 1’utile era il proprio tornaconto e non la conservazione
degli uomini».
Forse e vero, nessuno faceva
nulla per tutelare la vita, gli interessi dei corallini di quell’
epoca; ma e pur vero che, quando qualche iniziativa venne presa a favore
dell’attività (Codice Corallino, Reale Compagnia del Corallo), il
fallimento della stessa fu totale. |

Acquasantiera
di marmo del 1700 con bassorilievo raffigurante una
"corallina". Chiesa.di S. Maria
di
Costantinopoli. Torre del Greco
Comunque, gli uomini vivevano
veramente tra difficoltà e disagi, anche di ordine affettivo e fami
otto mesi di pesca (da Pasqua ai morti) si aggiungevano quelli necessari
per raggiungere le piazze sia di raccolta che di vendita, perché « ...
il corallo doveva portarsi ai negozianti lavoratori e questi si
trovavano in Genova e in Livorno».
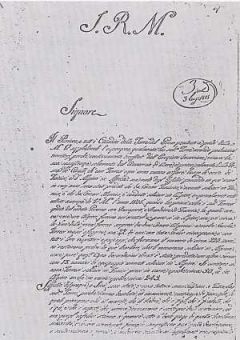
"Supplica" al Re Ferdinando IV di
Borbone
(1813): i Torresi chiedono un intervento presso
i Governi di Algeria e Tunisia per il
rilascio
di trecento "corallini" schiavi
in quei Paesi
Tale peregrinare era dovuto al fatto che Torre ancora non aveva la
lavorazione, sviluppatasi piuttosto tardi rispetto agli altri centri.
Tutta questa situazione, compreso il trasferimento della merce, esponeva
i corallini a ulteriori disagi tutt’altro che insignificanti: il
pericolo di essere derubati strada facendo di quel carico da cui
dipendeva la sopravvivenza delle famiglie, le condizioni da capestro
imposte loro dagli acquirenti che, in particolare a Livorno,
richiedevano sacrifici economici sino al 35% del corallo da
vendere, erano certamente i più sentiti.
Furono queste condizioni a far maturare fin dai primi decenni del ’700
l’idea di vendere e lavorare il corallo nella stessa Torre del Greco,
progetto che si materializzo solo nel 1790 con la costituzione della
«Reale Compagnia del Corallo». Essa sorse con un capitale sociale, la
cui sottoscrizione era aperta a tutti tranne che per un’aliquota
riservata ai soli torresi.
|