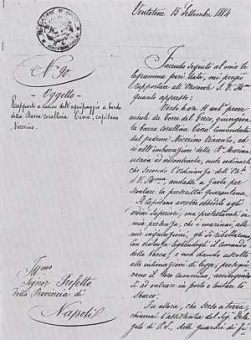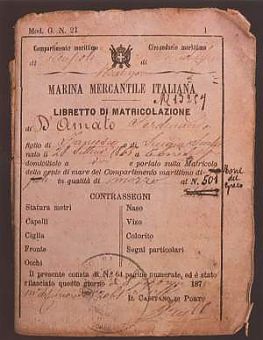|
Il suo scopo era di aiutare e di
agevolare ogni attività direttamente o indirettamente connessa al
corallo. Infatti, tra 1’altro doveva rifornire le barche di spago e di
funi, di "biscotti" a prezzo di costo, oltre che di anticipare
alle stesse ogni spesa occorrente durante la stagione di pesca.
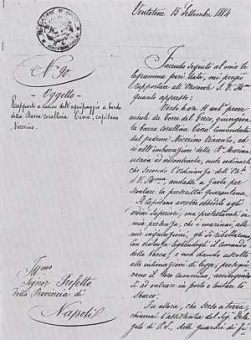
Rapporto
datato 15 settemre 1884 indirizzato
al Prefetto di Napoli: si espone 1’atteggiamento
tenuto dall’equipaggio della "corallina" "Cina",
che rifiuta il divieto di attracco a Ventotene
e 1’ingiunzione di quarantena a
Gaeta
Le era fatto obbligo
di aprire, con onere a proprio carico, una fabbrica per la produzione di
funi occorrenti alla pesca e un’altra, naturalmente, per la
lavorazione del grezzo.
La «Compagnia» aveva 1’esclusiva della compra- vendita del corallo e
se ai pescatori era assoluta- mente proibito cederlo ad altri, essa era
tenuta ad acquistarlo tutto ad un prezzo definito da dieci esperti.
La Società avrebbe poi provveduto a vendere sia il grezzo che il
lavorato, agevolandosi di esenzioni fiscali su quello esportato.
Purtroppo, pero, 1’impegno dei Borboni nel voler dare un certo
sollievo alla pesca e 1’impulso iniziale alla lavorazione « in loco
», non dettero il risultato auspicato. Come era fallita la
regolamentazione della pesca prevista dal «Codice Corallino»,
promulgato nello stesso 1790, cosi falliva la possibilità di togliere
Torre dallo stato di inferiorità rispetto a Genova e a Livorno.
Qui viene da chiedersi: fu un fallimento dei Borboni o dei torresi, i
quali, come tutti i meridionali, mal sopportano leggi e regolamenti?
Comunque da questi fallimenti i corallini si ritrovarono al punto di
partenza, a quella condizione di sempre, denunciata già dal giurista
Michele De Iorio nel 1788. |
Con ottimismo credeva nella validità
di una « Compagnia del Corallo »: « ...noi che siamo i padroni di
questo tesoro lo portiamo in tributo a Livorno
piangendo, pregando, implorando misericordia da quei negozianti ebrei,
in mezzo a mille spese e mille avarie ». In alcuni periodi, anche dell’800,
cio che maggiormente opprimeva i pescatori era il pochissimo danaro di
cui solo raramente disponevano, benché fossero «padroni» dei loro
gozzi: per «armare a corallo», infatti, erano sempre costretti a
ricorrere a prestiti al « cambio marittimo » che, se in teoria si
aggirava sul 20-25%, in pratica arrivava anche al 50%. I debiti venivano
saldati a chiusura di «stagione»; quando, pero, non si riusciva a
vendere subito il raccolto, la situazione diveniva drammatica e le
conseguenze si protraevano per anni. Cosi accadde ai Loffredo nel 1820:
« La pesca fu eseguita in Corsica; del ricavato non si poté conoscere
la somma perché venne portato a Livorno e cola rimase invenduto per due
anni. E perché occorreva pagare le somme e gli interessi maturati si
dove pignorare su quella piazza ».
Erano episodi piuttosto frequenti, dovuti anche al disuso dell’ornamento
di corallo verificatosi dopo la caduta di Napoleone. Per 1’incertezza
di portare «il pane a casa», molti disertarono, in quell’epoca, l’attività
di pesca e tra questi i Loffredo, che nel 1830 pensarono di sbarcare il
lunario in tutt’altro modo:
«Pochi erano quelli che si davano di ciò premura (cioè di attrezzarsi
per la pesca, n.d.a.); noi si pensò di trovare altro mezzo per vivere.
Pensammo io e i fratelli di andare sulla spiaggia di Salerno a
raccogliere la legna da fuoco per venderla. Venuto maggio, poi, osservammo
anche che due barche caricavano pomodori per portarli alle città di
Roma e di Livorno e risolvemmo a fare l’istesso anche noi».
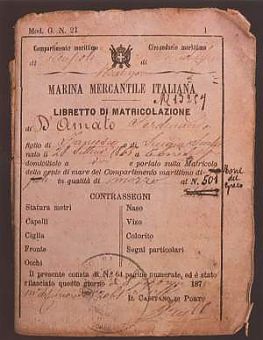
Libretto
matricolare di Ferdinando D’Amato
di Torre del Greco, imbarcato su una "corallina"
all’età di 10 anni e 8 mesi (1876) |