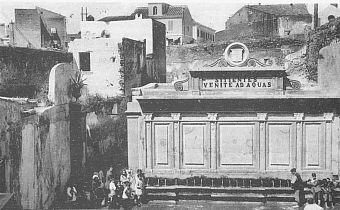| Torre e il corallo pag. 6 di 17 | ||
|
In genere le "marticane" si specializzavano ognuna per il prodotto) o alimento) portato da Torre; c’era, quindi, quella che riforniva di biscotti, 1 altra invece di reti o di acqua e cosi via. Spesso, poi, proprio questo carico sugge- riva un soprannome da dare a1 «padrone» della barca. A Torre, ancora oggi se ne ricorda uno: «’u Bove da Maccarunara» il cui carico, come intuibile, era costituito da maccheroni.Benché faticosa, in quanto ogni operazione era affidata alle braccia dell’uomo, questa pesca non presentava i problemi e le incognite di una vera pesca, perché il corallo c’era e si sapeva anche dove: bastava calare 1’ingegno e il gioco era fatto. Infatti, il Mazzarelli dice: «Ma la scoperta dei banchi di Sciacca ebbe, pero, secondo me, una influenza punto buona su quelle che erano le qualità migliori dei corallini torresi quando si cimentavano alla pesca sui veri banchi di corallo. La pesca sui banchi di Sciacca, pesca come si e detto relativamente facile, li disavvezzo alle rudi e pazienti fati- che della pesca sui veri banchi, li rese in certo qual modo pigri e poco desiderosi di ritornare ai vecchi banchi o di cercarne di nuovi sulle nostre coste, o se vi andarono non ebbero più, in generale, quella pazienza e quella abilita di sfruttare gli scogli coralli- feri che avevano i loro padri. Direi quasi che i banchi di Sciacca con le loro enormi ricchezze e la prospettiva del facile bottino hanno male abituato i no- stri corallini torresi, che in fondo non saprebbero, forse, persuadersi di andare ora a pescare su banchi di ben più difficile sfruttamento, come sono per la massima parte quelli dei nostri mari». Il materiale che affluiva in ogni centro interessato (Genova, Livorno, Trapani e Torre) era tanto quanto non se ne era mai visto sollecitandone l’accaparramento da parte dei grossi commercianti. Un esempio di quella «febbre» 1’ho trovato nei documenti della Ditta Raffaele Costa di Genova, dai quali risulta che in soli 19 giorni del giugno 1880, la stessa acquisto 324 casse contenenti ben 20 tonn. di grezzo. Il corallo siciliano comprato dai Torresi era stato veramente tanto e in proposito il Tescione scrive: « Per avere un’idea della ingente quantita di pro- dotto che si riverso a Torre, basta considerare che le spuntature ed i frammenti di corallo Sciacca furono sparsi quasi come ghiaia per strade, piazze e giardini pubblici e trattavasi di prodotto tutt’altro che inadatto al lavoro ». Quest’epoca leggendaria per il binomio « Sciacca- Torre del Greco » rappresento una vera epopea; le fabbriche nel 1880 erano più di 80 ed i lavoranti superavano le 4000 unita con la abituale prevalenza degli elementi femminili. Da noi accorrevano mercanti da tutto il mondo richiamati dall’eco dell’eccezionale fenomeno e dalla curiosità di toccare con mano 1’abbondanza di quel corallo che, pur essendo mediterraneo, aveva un colore tutto particolare. Si lavorava alacremente per soddisfare le richieste che pervenivano da ogni Paese, mentre nel contempo nei depositi della città si ammassavano decine e decine di quintali di quel «morto» ma bellissimo «Sciacca». E fu proprio in conseguenza di tali acquisti se dalla favola da «Mille ed una Notte» vissuta da Torre si passo alla crisi ed infine a vere tragedie. Si sarà certamente udita qualcuna delle espressioni «purtroppo non siamo al tempo di Sciacca» o anche « speriamo non si verifichi mai più quanto accadde nell’epoca di Sciacca », nelle quali troviamo sintetizzata la bivalenza di quel fenomeno, simile ad un Giano bifronte: con un viso sorridente e 1’altro piangente. Il viso sorridente 1’abbiamo gia visto; il piangente, fu dovuto allo stesso corallo che aveva dato lavoro e ricchezza, e per il cui possesso si scateno una vera «follia». Infatti, l’assorbimento da parte dei mercati di quell’eccesso di pesca e della conseguente sovraproduzione, nei molti anni in cui si verifico, ebbe in se qualcosa di miracoloso che non poteva reggere all’infinito. Il momento fatidico arrivo quando, con la completa saturazione del mercato, coincise un deciso affievolimento dell’impiego dei nostri manufatti. Gli ordini arrivavano a Torre in numero sempre decrescente e se inizialmente richiesero solo un rallentamento delle lavorazioni, alla fine ne decretarono la paralisi completa. |
A
questo punto, ma era gia tardi, risulto in tutta la sua imponenza 1’errore
di quella corsa agli acquisti, che aveva depauperato gli operatori
Torresi nelle loro risorse finanziarie. Essi, pertanto, si trovarono
nell’impossibilità di fronteggiare la crisi essendo il loro
patrimonio costituito solo da quel corallo che ormai più nessuno
voleva. Chi aveva ritenuto vantaggioso investire i propri capitali acquistando lo «Sciacca» a 7-5 L./Kg. veniva, quindi, a trovarsi con una merce che, invece di rivalutarsi non foss’altro che per il tempo trascorso, quotava meno di un terzo del prezzo di acquisto. Si assistette, allora, alla distruzione di vecchi patrimoni e a dissesti finanziari che si susseguirono ovunque. 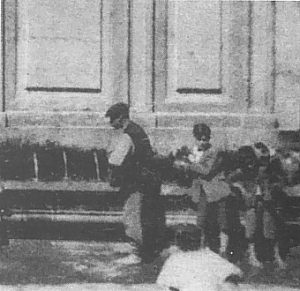 Particolare che ritrae il noto "lustraiuolo" Magliulo Vincenzo detto ’a Paoncella Prime ad essere
colpite furono le piccole fabbriche sorte nel momento di euforia e che
tra Genova, Livorno e Torre ammontavano a molte centinaia. Fu, insomma,
un periodo veramente nero, caratterizzato anche da manifestazioni di
piazza dovute alla miseria conseguente alla mancanza di lavoro per tutta
la gente che viveva delle attività del corallo. E per Torre fu anche un
periodo di incertezze sui provvedimenti da adottare e da chiedere: se da
una parte i fabbricanti e commercianti, sostenuti da quelli di Genova e
di S. Margherita Ligure, oltre che dagli operai corallari di Livorno e
persino dalla Ditta «Heilgers e C. » di Calcutta, chiedevano la so-
spensione della pesca in Sicilia sperando di arginare 1’affluenza di
quel materiale, dall’altra parte i pesca- tori ne reclamavano la piena
liberta per garantirsi 1’esercizio del proprio mestiere: interessi,
dunque, contrastanti, che certo non aiutavano al superamento di quel
triste momento. |
|