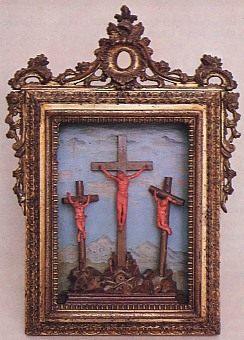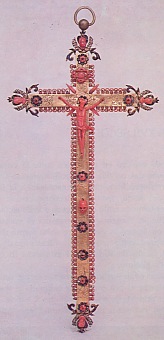|
Fu detta "montagna" per
le sue dimensioni e per la complessità dell'opera, famosa non tanto per
il soggetto, allora piuttosto ricorrente, della vita di Cristo e della
Madonna, quanto per la ricchezza di scene e di personaggi. Tra i tanti
gruppi di cui si componeva figuravano due interi presepi, una fuga in
Egitto, venticinque giochi d'acqua, quattro cappellette e molte
figurazioni relative alla Passione, alla Crocifissione e alla
Flagellazione.
In questo stesso secolo Genova non è da meno; la sua produzione, a
differenza di Trapani, non presenta alcuna peculiarità, ma la qualità
dell'incisione è eccellente e 1'attività abbastanza diffusa. Gli
specialisti sono più di 150, mentre le maestranze addette alle operazioni
per la lavorazione dei grani (taglio, tornitura, pulitura, foratura) sono
numerosissime e particolarmente attive nell'entroterra di Val Bisagno e
Val Polcevera.
La produzione "commerciale" di Genova veniva assorbita
prevalentemente dall'India, dalla Spagna, dall'Armenia, le quali pero
costituivano solo i centri da cui i manufatti prendevano altre
destinazioni. L'arte dei "corallieri" genovesi, molto ben organizzata,
era suddivisa tra "mercatores", cioè commercianti per lo più
borghesi, e "artifices", lavoranti della plebe. L'importanza di
questa estesa categoria si rileva dal fatto che, fin dal 1477, essa aveva
chiesto al Governo la propria " universitas ", sottoposta a
regole fisse dalla stessa formulate.
Tali regole, dette "capituli", approvate solo nel 1492 e
successivamente modificate, disciplinavano l'attività e i rapporti tra
gli addetti, compresa l'assistenza reciproca, ed i doveri da rispettare.
Ad esempio, ogni sabato due "maestri" dovevano andare in giro
tra i corallieri raccogliendo le loro "elemosine". una meta era
devoluta alle giovani da marito, l'altra metà ai poveri ammalati e alle
partorienti, sempre appartenenti a quell'arte. Coloro che si fossero
rifiutati di adempiere a tale dovere venivano puniti con un'ammenda di ben
3 lire.
Nel 1500 si trasferì nella città ligure il maestro Filippo Santacroce,
oriundo di Urbino, il quale portò 1'incisione a quel livello artistico
che rese Genova uno dei capisaldi della scultura di corallo. La città non
aveva molto da invidiare a Trapani tanto che, quando Andrea D'Oria volle
donare a don Diego di Cordova coralli scolpiti, non dovette rivolgersi
altrove bastandogli attingere ai lavori del valente Santacroce.
L'uso del corallo, sempre molto diffuso, diveniva anche più
differenziato: dalla medicina all'ornamento, all'arte.
Alla prima si destinava il corallo "terragno", mentre il resto
andava ai soliti "paternostri ", alle olivette e alle nascenti
opere di scultura, delle quali qualche esemplare venne prodotto, oltre che
a Genova e Trapani, anche a Napoli, Venezia, Parigi, Norimberga. |

Capezzale di argento dorato e corallo.
Trapani - Sec. XVII - Coll. privata
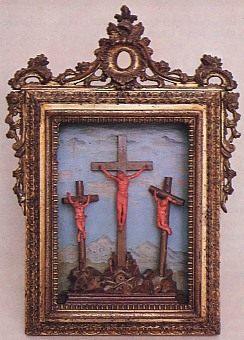
"Cristo tra i ladroni" - Lavoraz.
siciliana
Sec. XVII - Museo Liverino
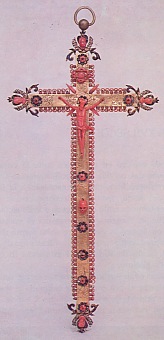
Crocifisso su rame dorato e corallo "Sciacca"
Trapani Sec. XVII - Museo Liverino
|