|
«...
vari rami di lave formaronsi nell’alto del vulcano. Nella medesima
vetta si fecero pure molte fenditure, ove durante qualche giorno il
fuoco traboccava violentemente. Si osservano in questa tavola due rami
di lave essersi trasportati verso il mezzogiorno. Diede fuoco fino a
tutto il mese di Ottobre. Avvertironsi pure de’ tremuoti nelle
vicinanze del Vesuvio ...».
Lo
stesso fenomeno eruttivo è descritto nel seguente brano del Duca della
Torre (1795), il quale afferma anche che su di esso non esiste alcuna
documentazione scritta:
«Cominciò
circa la metà di Settembre (1790), formando diversi rami di lava sopra
la sommità del vulcano; nel quale si fecero varie crepature, e tutte
gettavano fuoco in alcuni giorni con molto impeto, ed in altri con poco.
Due rami di lava si dilungarono per un lungo tratto verso la parte di
mezzogiorno. Durò il fuoco fino alla fine di Ottobre, e fu accompagnato
da diversi scotimenti di terra nei soli contorni del Vesuvio. Di questo
incendio non vi è relazione stampata ...».
Effettivamente
su questa eruzione, che possiamo definire intraciclica, nulla si conosce
a tutt’oggi, ma è verosimile credere che si sia trattata di una
eruzione stromboliana, forse più intensa delle altre, comunque facente
parte della normale attività stromboliana del ciclo eruttivo in atto.
Ciò deriva dall’interpretazione del seguente brano di Vigee (1790) e
da una gouache dell’eruzione attribuita al D’Anna (fig. 5).
«...
raggiungere un altopiano dal quale riuscimmo a vedere una immensa colata
di lava scorrere proprio sotto i nostri piedi ... Quella volta il
vulcano era più furioso che mai, ma non distinguendosi di giorno il
fuoco, vedemmo uscire dal cratere, frammisto a nubi di cenere e di lava,
solo un enorme fumo biancastro ... Finalmente venne la notte, e il fumo
si trasformo in fiamme ... Fasci di fuoco che si proiettavano fuori dal
cratere in rapida successione, lanciando da ogni parte pietre
arroventate, che ricadevano con fragore. Contemporaneamente dalla cima,
una cascata di fuoco scorreva in discesa percorrendo una superficie di
quattro o cinque miglia. Anche un ’altra bocca del vulcano posta più
in basso era infiammata ... La folgore che dirompeva dal centro della
montagna faceva rimbombare tutti i dintorni, talché la terra tremava
sotto i nostri passi ...». Vigee (1790).
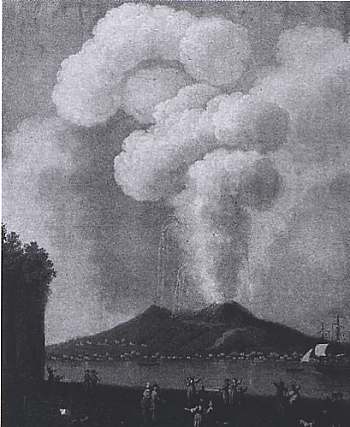
Fig.
5 –
Gouache di Alessandro D’Anna della fine del ’700 mostrante il
Vesuvio in eruzione nel 1790.
Da
tutti questi brani e da quelli che seguono immediatamente si evince,
inoltre, che l’attività eruttiva doveva essere limitata alla zona
craterica e per lo più era ricostruttrice del cono vesuviano andato
distrutto con l’esplosione del 1779. Quindi le aree pedemontane, e
forse le stesse popolazioni residenti, non risentivano di questa
attività eruttiva. E’ ovvio allora che chi descriveva lo stato del
vulcano in questo periodo, sia stando dalla falda settentrionale che da
quella costiera, non aveva un’idea precisa di quanto accadeva alla
sommità del cratere e pertanto dichiarava, come si riporta di seguito,
che lo stato di inattività del vulcano perdurava da circa 15 anni.
«...
Non sono ancora 15 anni (riferendosi all’eruzione del 1779; N.d.R.),
che le campagne e gli edifizi di
Ottajano furono devastate dalla gran copia di pietre infocate lanciate
dall’ignivome monte ...». Anonimo (1794 b).
... Dalla memorabile eruzione del 1779 ... fino a questa (eruzione del
1794; N.d.R.) ... non n’è avvenuta veruna notabile ...». Scotti
(1794).
L’attività
eruttiva intracraterica degli ultimi due anni che precedettero l’eruzione
del 1794 è ben documentata dal seguente brano di Tata (1794):
«...
Erano scorsi circa due anni, dacché non era seguita alcuna esplosione di
lava, neppure dalla sommità del cono. Ne mesi di Maggio e di Giugno
dell’anno scorso(1793; N.d.R.) vi fu appena una continuazione, che
durò qualche tempo, di quei soliti spruzzi di scorie semiliquide, mentre
in un lato del cratere verso il Nord del cono vi era un piccolo volume
di lava in ebollizione, che non uscì mai dal suo recinto, benché i muggiti, che si udivano, fossero stati molto imponenti ... Da questa
epoca in poi il Vesuvio non fece altro, ch’eruttar fumo ... a riprese
... qualche volta arena e cenere, finché tutto il cratere si livellò in
modo, che rappresentava una quasi perfetta pianura; e infine cessò anche
di gettar fumo ...».
Questo
brano di Tata ci testimonia che la depressione intracraterica, formatasi
a seguito dell’esplosione del 1779, era ormai del tutto colma e
livellata e lo stesso cono era ormai ricostituito totalmente. Ma una
idea più precisa di quale potesse essere la morfologia del cono e del
cratere prima dell’eruzione del 1794 si può avere, oltre che dalle
figg. 4 e 5, anche dalla fig. 22 (in realtà la tav. VIII di Hamilton,
1795). Inoltre, si riscontra una carenza di informazioni circa le
dimensioni del cratere e del cono vesuviano; a tal proposito, solamente
il seguente brano riporta una breve descrizione della forma e delle
dimensioni del cratere prima dell’eruzione:
«...
La sommità ignivoma ha la forma d’un bacino un poco ovale, il cui
diametro per la direzione di Est ad Ovest ha da circa 300 tese (circa
585 m; N.d.R.) e ne ha 100 (circa 195 m; N.d.R.) di profondità ...».
F.M.D.C.A.T. (1994).
Come
si osserva, tali parametri non sono poi così dissimili da quelli
attuali. |