|
imponenti
lahars, causati dalle abbondanti piogge che dilavarono dai versanti del
complesso vulcanico una massa consistente di piroclastiti poggiate in
modo instabile, che raggiunsero e distrussero quasi tutti i centri
abitati ubicati alle falde dell’edifico vulcanico.
L’attività
post-1631
Dopo
l’eruzione del 1631 il Vesuvio è stato attivo quasi ininterrottamente
fino al 1944, data dell’ultima eruzione. L’analisi delle
innumerevoli cronache storiche, affiancate da osservazioni e misurazioni
scientifiche, in modo sistematico dal XIX sec., ha permesso di notare
una certa ciclicità nel comportamento del vulcano (Nazzaro, 1985; 1997)
che si è manifestato con una costante ripetizione delle seguenti fasi:
1. inizio dell’attività vulcanica con la formazione di un conetto all’interno
del cratere che si accresce per lancio di scorie (attività
stromboliana), alternata a tranquille effusioni laviche che invadono
tutto il fondo craterico e ne innalzano il livello (attività
hawaiana);
2. colmamento del cratere con trabocco dall’orlo di piccole colate
laviche ed innalzamento del cono vesuviano; questa fase può a volte
essere interrotta da eruzioni intermedie, con esplosioni di bassa
e media energia seguite da fuoriuscita di lave dal cratere o da bocche
createsi lungo fratture esterne al cono vulcanico ma sempre in
prossimità del cratere (bocche subterminali);
3. quando i materiali non riescono più a contenere la pressione troppo
elevata del magma saturo di gas, allora si verifica l’eruzione
parossistica finale questa è caratterizzata da energia me- dio-alta
che si esaurisce in pochi giorni, dopo aver espulso notevoli volumi di
lave, ceneri e lapilli con forti esplosioni al cratere centrale; le
esplosioni possono provocare la distruzione parziale del cono
precedentemente costruito generando temporaneamente una depressione
craterica più o meno allargata; i detriti
derivanti dal crollo delle pareti crateriche vanno ad intasare la parte
alta del condotto eruttivo ostruendolo;
4. segue un periodo di riposo o di inattività della durata media
di 7 anni, durante il quale il condotto è ostruito e solo una leggera
attività fumarolica all’interno del cratere svuotato è presente. I
cicli eruttivi determinanti la fase interpliniana tra il 1631 ed il 1944
sono stati 17 (Tab. I). Alcune eruzioni finali si sono generate da
fratture eccentriche, al di sotto dei 500 m di quota, ed hanno dato
luogo a coni di scorie allineati ed effusioni laviche. Di queste
eruzioni le più importanti negli ultimi secoli sono state quelle del
1760, del 1794 e del 1861.
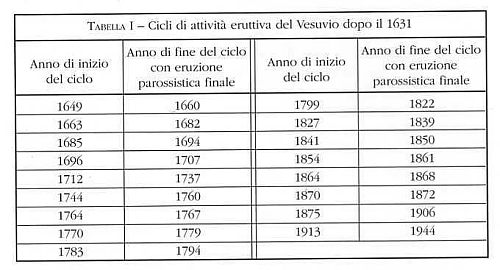
L’ultimo ciclo, durato 31 anni, è iniziato dopo 7 anni di riposo e si
è concluso con l’eruzione parossistica finale del marzo 1944 (Pesce R. Rolandi, 1994). Da quella data il Vesuvio
è in stato di quiescenza: un
tempo molto più lungo dei precedenti periodi di riposo. Questo
significa che il suo attuale stato non può più essere inquadrato nella
normale successione ciclica di fenomeni eruttivi descritta
precedentemente. In tal caso, è verosimile che la ripresa dell’attività
vulcanica vesuviana si |