|
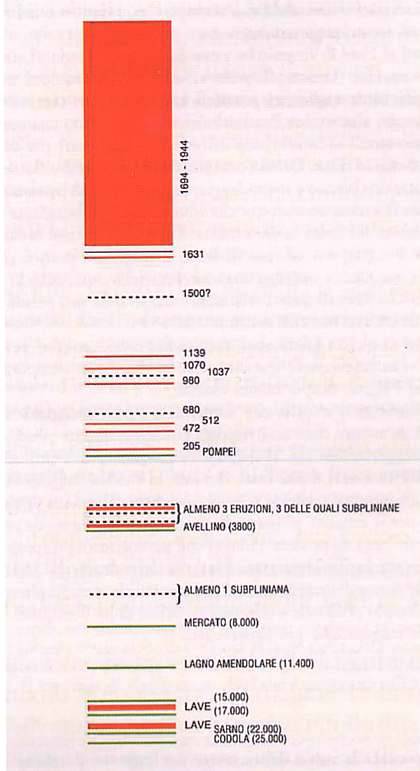
Fig.
3 –
Cronologia schematica delle principali eruzioni del Somma- Vesuvio (dis.
modif. da: Gasparini R Musella, 1991). In verde sono rappresentate le
eruzioni pliniane. In rosso le eruzioni che hanno dato lave ed il
periodo eruttivo interpliniano 1631-1944. In tratteggio sono indicate le
eruzioni di dubbia attribuzione cronologica. Le date in parentesi
indicano 1’età delle eruzioni a partire dal presente; quelle non in
parentesi indicano 1’anno dell’era cristiana in cui e avvenuta 1’eruzione.
possediamo
la descrizione più antica, appunto quella tramandataci da Plinio il
Giovane nelle sue lettere a Tacito. Essa e di fondamentale importanza
anche per l’archeologia dei paesi vesuviani: fu la causa della morte
di oltre 2000 persone e del seppellimento o della distruzione di
numerosi centri abitati romani che sorgevano alle falde del vulcano, tra
cui Pompeii, Herculaneum e Stabiae. L’attività eruttiva
continuo negli anni successivi (fig. 3) caratterizzando una fase
interpliniana costituita da eventi eruttivi di moderata energia e di
tipo misto culminanti, nel 472 d.C., con una grande eruzione subpliniana
nota come "eruzione di Pollena", caratterizzata dalla
emissione di imponenti colate piroclastiche e nubi ardenti. Meno
conosciuta e l’attività del Vesuvio durante l’epoca medioevale
(fig.3), perché sono scarse e di dubbia attendibilità le fonti scritte
che danno informazioni di eruzioni vesuviane avvenute in questo periodo.
Secondo alcuni autori (Rosi R Santacroce, 1986; Rolandi R Russo, 1989),
sono storicamente accertate solo undici eruzioni accadute prima del
1631, ma gli affioramenti sul terreno di vulcaniti rapportabili a queste
eruzioni sono comunque scarsi e di dubbia attribuzione cronologica.
Tuttavia sembra ormai accertato che l’eruzione, a carattere
essenzialmente esplosivo, avvenuta nel 1139 probabilmente chiuse un
lungo periodo di eruzioni caratterizzanti la fase interpliniana seguita
all’eruzione del 472 d.c. Quindi una lunga inattività sembra aver
caratterizzato il vulcano vesuviano dal 1139 al 1631, quando con una
nuova ed imponente eruzione subpliniana, sicuramente la più disastrosa
del millennio, il Vesuvio riprese la sua normale attività eruttiva. L’eruzione
del 1631, secondo alcuni autori (Rolandi R Russo, 1993; Rolandi et al.,
1993; Rosi et al., 1993), fu senz’altro esplosiva ed emise una gran
quantità di vulcaniti da caduta aerea (lapilli e ceneri), che si
depositarono verso settentrione, e da flusso piroclastico, che scorsero
invece lungo il versante costiero alterando la topografia dei luoghi. La
contemporanea fuoriuscita o meno di lave e ancora oggetto di
discussione. L’effetto più imponente di questa eruzione fu la
decapitazione del precedente cono vesuviano, che risultò abbassato di
ben 450 m, con formazione di un nuovo cratere, molto svasato (Nazzaro,
1989). La fase finale dell’eruzione fu caratterizzata da |