|

Guarigione del marinaio torrese Luca
Velardi.
Sono 23 le tavolette conservate nella sua casa.
Vi partecipavano i collegiali, i frati
cappuccini, i chierici e i confratelli delle congregazioni dell’Assunta
e del Santissimo Sacramento che
accompagnavano la statua della Madonna con le torcette.
La festa dell’Immacolata Concezione era solennizzata a Torre non 1’8
dicembre, ma il 29 settembre, ricorrenza di san Michele, quando
ritornavano i marittimi dalla pesca del corallo, quale devoto omaggio
dei Torresi alla Vergine Imma- colata. La devozione all’Immacolata era
antica e nella parrocchia di Santa Croce vi era una bellissima cappella
a lei dedicata, molto frequentata, specialmente dalle donne.
Il beato la rinsaldo con una novena in suo onore e facendo costruire
subito la statua dell’Immacolata che, durante 1’eruzione del 1794,
era andata distrutta. La festa e la processione dell’Assunta si
tenevano il 15 ago- sto ed erano sostenute dalla Congregazione dello
stesso titolo. Con la nota eruzione del 1794, essendo stato distrutto l’ora-
torio della Congregazione, la novena si tenne temporaneamente nella
chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, coadiutoria della parrocchia di
Santa Croce.
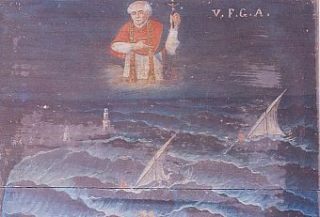
Ex
voto dello scampato naufragio
Vincenzo Romano accordo il permesso, sia da economo curato che da
parroco, della festa e processione. Nel decennio francese fu sospesa la
festa e la processione, ripresa poi nel 1816. Sospesa di nuovo « per
giusti motivi », fu ripresa nel 1823 senza interruzione fino alla morte
del Romano e proseguita dopo con l’approvazione del nipote, don
Felice, eletto parroco di Santa Croce.
Un’altra festa mariana si svolgeva a Torre del Greco 1’8 settembre
(ricorrenza della Natività della Vergine), poi trasferita all’ultima
domenica del mese nella cappella di Santa Maria di Costantinopoli.
Secondo la tradizione, all’origine della devozione sarebbe stata un’immagine
della Vergine con il Bambino in grembo, ritrovata nei pressi della costa
africana da tale Andrea Maldacena di Torre, «famoso corsaro e flagello
dei Turchi». Ritornato in patria, il Maldacena avrebbe donato la statua
al principe di Stigliano, signore di Torre del Greco, che aveva poi
edificato la chiesa per soddisfare la
devozione degli abitanti per quell’immagine.
La cappella che era stata effettivamente eretta dai Carafa, principi di
Stigliano, fu a lungo amministrata dai governatori della chiesa
parrocchiale di Santa Croce e poi ceduta al Pio Monte dei Marinai, nella
seconda meta del Seicento ’4. Nel 1817, quando Vincenzo Romano era
parroco, fu istituita in detta chiesa dal sacerdote Gerardo Palomba,
cappellano di bordo, l’aggregazione al Santissimo Cuore di Gesù.
Don Gerardo, inoltre, «per vieppiù infervorare la devota gente alla
venerazione» fece fare un bel quadro in Roma e lo fece benedire dal
beato, «che fu il primo ascritto alla pia opera». Nella chiesa di
Santa Maria del Carmine si venerava poi « un’assai mirabile
immagine» della Madonna sotto questo titolo.
La devozione popolare per quest’ultima, gia ma- nifestatasi nel XVI
secolo ebbe grande impulso in seguito alla peste del 1656. La chiesa
dell’antico convento era ormai abbandonata, dopo la soppressione
innocenziana del 1652, resasi necessaria per le condizioni in cui
versava 1’intero complesso a seguito dell’eruzione del 1631. Durante
la peste molti cadaveri vennero lasciati senza sepoltura all’interno
della chiesa, finche la Vergine, secondo la tradizione, non apparve due
volte in sogno ad un contadino, lamentando che la chiesa a lei dedicata
e gia preservata dalla lava, fosse stata tramutata « in abominevole
stanza d’ossa e carnami».
A seguito di ciò, il parroco di Santa Croce provvide a far liberare la
chiesa dai cadaveri che furono seppelliti non lontano, in una località
dove fu successivamente edificata la cappella di Santa Maria del Pianto.
Diffusasi la notizia della miracolosa apparizione, la devozione per 1’antica
immagine ebbe un grande impulso: gli appestati si facevano ungere con
olio della lampada che vi ardeva dinanzi; molte donne lasciavano, in
segno di ringraziamento per le grazie ricevute, vesti e ornamenti,
anche preziosi, per adornare il
simulacro della Madonna. In seguito, fu istituita una mastria che
curasse la ricostruzione della chiesa e fu ripristinata la processione.
La spinta della devozione popolare fu tale da consentire anche il
ritorno dei carmelitani, che andarono via definitivamente nel 1809 a
causa del decreto di soppressione dei conventi ". Il beato era de-
voto della Madonna del Carmine e in fin di vita ricevette « le
indulgenze dell’abitino del Carmine a cui era iscritto». Durante la
vita predico spesso nella festa del Carmine.
Un’altra festa mariana si svolgeva nella cappella di Santa Maria la
Bruna il secondo giorno dopo Pentecoste; ad essa i fedeli partecipavano
con «concorso mediocre », secondo le affermazioni del parroco Raiola.
Le grandi calamita pubbliche che funestarono gli anni in cui visse
Vincenzo Romano furono numerose e misero a dura prova la sua fibra di
uomo e di apostolo. Carestie, epidemie, eruzioni vesuviane si
susseguirono o si alternarono rendendo oltremodo difficile la vita degli
abitanti di Torre del Greco, che mai si arresero di fronte a questi
tragici avvenimenti.
Nel 1764 imperverso una terribile
carestia che provoco la mancanza anche delle cose più necessarie, come
il pane. Le pestilenze in genere erano procurate da quelli che erano
reduci dalla pesca del corallo sulle coste africane e rimanevano
contagiati. « Nel 1815 vi fu in Torre la pedecchiaia, ed il Venerabile
si presto senza indugio ed a preferenza accorreva ai poverelli ai quali,
quando poteva, lasciava danaro per le medicine ed altro». Ma le
calamita che maggiormente funestarono Torre del Greco furono le eruzioni
vesuviane che videro ogni volta protagonista il beato.
|
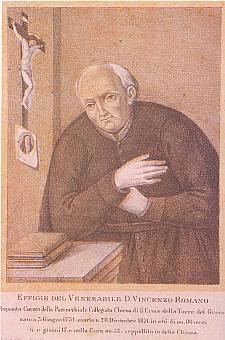
Il Beato in un incisione di
fine secolo XIX
Al tempo del suo ministero il Vesuvio fu in continua attività eruttiva.
Il timore e lo spavento invase tutti e ognuno credevasi or ora essere
arso; molta gente torrese trasse in fretta, tremante e piangente presso
di lui a quell’imminente pericolo. Vincenzo da ciò prese occasione ad
eccitarla negli atti di penitenza e chiedere perdono a Dio dei propri
falli. Si dileguo la nube, e ciascuno fiducioso ritorno alla propria
casa».
Ma 1’eruzione che maggiormente danneggio Torre fu quella del 1794, che
in breve tempo distrusse quasi completamente la città. Anche 1’antica
chiesa parrocchiale di Santa Croce, una delle più belle dell’archidiocesi,
fu seppellita dalla lava. Resto in piedi solo il massiccio campanile,
sotterrato per meta, come 1’albero ancora visibile di una nave che
affonda.
La popolazione torrese in preda a uno spavento senza pari tra grida e
pianti ininterrotti, cerco rifugio a Castellammare di Stabia, Cava dei
Tirreni, Sorrento ed altri paesi vicini. La maggior parte degli
ecclesiastici si era ricoverata a Napoli per chiedere aiuto al cardinal
Capece Zurlo e al re Ferdinando IV. Le vittime dell’eruzione furono
circa 15, per lo più anziane e malate, incapaci di mettersi in salvo,
tra cui un sacerdote.
Il parroco Gennaro Falanga, ormai anziano e inabile, si era ritirato in
una sua casa di campagna ed aveva suggerito al cardinale il nome di don
Vincenzo Romano. Cosi questi, costretto ad ubbidire, fu il ricostruttore
materiale e spirituale della parrocchia, che guido prima da economo cu-
rato e poi da preposito curato. All’eruzione del 1794 tennero dietro
quelle del 1804, 1805,
1810, 1813, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821,
1822, 1831.
In mezzo a tutte queste calamita Vincenzo Romano mai di- serto il campo.
Testimonio un fedele: « Mi ricordo che il Servo di Dio non si e
allontanato mai dalla sua residenza, ed ancora quando tutti fuggivano
per 1’eruzione del Vesuvio, il Venerabile non si allontanava mai dalla
parrocchia. E ricordo ben’anche che nel celebre terremoto di Sant’Anna
nel 1805, mentre tutti dormivano in campagna per la paura, il Venerabile
non si allontano, e mi incoraggiava a starmene in casa a dormire».
Accanto al beato, vi fu in quella circostanza un altro grande santo:
Francesco Saverio Bianchi che esorto tutti a pregare Dio per allontanare
questo flagello. Vincenzo Romano raccolse 1’invito e in una predica
mensile ai sacerdoti tratto del compito di mediatori tra Dio e il popolo
dicendo loro: «La terra tutta e inondata dal torrente d’iniquità;
queste provocano lo sdegno di Dio e ci tirano addosso ogni sorta di
castighi; e già li sta patendo questo nostro paese, ed in mare, essendo
stati molti nostri marinari chi predati da turchi, chi ammazzati e chi
infettati dall’aria contagiosa son passati all’altra vita, ed in
terra, nelle campagne essendo state più massarie devastate dalla lava
vesuviana e in mezzo all’abitato, dove si vede buona parte di nostri
cittadini oppressi dalla povertà e da altri guai... ed il fuoco che al
presente fa spaventevole fragore nel monte Vesuvio par che ci minacci e
sterminio e rovina, e chi riuscirà a fermare 1’impetuoso torrente di
ogni sorta di enormi peccati?...
Non si sa: a noi, a noi sacerdoti che siamo i mediatori tra Dio e il
popolo s’appartiene». La testimonianza del nipote don Felice Romano
coglie bene l’animo del beato durante le funeste eruzioni vesuviane:
Il Venerabile Vincenzo più che mai dimostro la sua cristiana speranza,
la sua fiducia in Dio e nei meriti di Gesù Cristo nelle tristissime
circostanze nelle quali il Vesuvio con 1’eruzione di la- ve di fuoco
portava dappertutto lo spavento, la desolazione, la distruzione. Egli
pero non si scoraggiava, ma convocato subito il clero ed il popolo
inter vestibulum et altare, si affidava all’arme più possente per
abbattere 1’inferno, al mezzo più efficace per
calmare lo sdegno di Dio, alla chiave più facile dei divini tesori,
delle celesti misericordie, voglio dire alla preghiera. Soleva in queste
occasioni, con bei sentimenti, eccitare nel clero e nel popolo insieme
con la penitenza la fiducia in Dio.
Si vedeva pregare con tanto fervore e fiducia in Dio ch’era di esempio
a tutti gli astanti. Fu perseverante nella preghiera in simili eventi,
poiché passava a spingere il popolo a fare la processione di penitenza
portando per Torre 1’immagine della Madonna Addolorata, il santissimo
legno della Croce e la statua del principal patrono San Gennaro.
Ritornando in chiesa, seguitava a pregare. In tutto il tempo che
duravano le litanie dei Santi e le lauretane nella chiesa parrocchiale
si vedeva il Venerabile molle di lacrime perseverando nelle preci,
nihil haesitans.
Giunta la processione in mezzo della Piazza del- la Torre, egli soleva
dare un sentimento col quale eccitava il popolo alla penitenza ed alla
speranza di ottenere da Dio pietà e merce. Nel dare questo sentimento
si vedeva animato da tanta fede e speranza che sembrava un altro Mose
capace a disamina- re lo sdegno di Dio, si fervorose erano le sue
pubbliche preci che indirizzava al Cielo alla presenza di tutto il
popolo. Ed una volta il Signore si benigno in una maniera tutta
prodigiosa di accogliere la preghiera piena di confidenza del Servo suo.
Nel 1822 vi fu una eruzione desolatrice di cenere e di lapillo. Nel più
fitto meriggio si annotto 1’orizzonte in maniera che si camminava a
tentone, e si dense furono le caligini che si dovettero accendere i
lumi. Che terrore! che spavento! Il pianto, i gridi si sentivano da per
tutto, mestizia, desolazione.
Il Venerabile, non ostante che aggravato dal peso degli anni, divenuto
zoppo pel femore fratturato [sic], pieno di acciacchi, pure
animato dal suo zelo, dalla sua sicura speranza, giusto il suo solito
invito tutti alla preghiera pubblica, esorto alla processione di
penitenza, e strascinandosi a stento sino al mezzo della piazza, in quel
buio di mezzo giorno tenne al gran popolo si commovente discorso che
tutti piangevano si pel castigo sovrastante, si per la vista del vecchio
Pastore che tra le lagrime ed i sospiri si offriva a Dio nella sua
confidente preghiera come mediatore tra Iddio ed il popolo. Tanto basto
che le caligini incominciarono a diminuire pian piano sino a sgombrarsi
totalmente in guisa che uscimmo nel mezzo giorno di notte, e nelle ore
pomeridiane ci ritirammo di giorno.
|