'A summulella
di Peppe D'Urzo
Per
storica assonanza si potrebbe far derivare la parola "summulella"
(in dialetto torrese) o "Semmolella" (in dialetto napoletano)
alla famiglia Semola. Gli insigni fratelli Vincenzo e Mariano (uno zio,
Nicola era un famoso avvocato tra i più valenti professionisti del foro
partenopeo), originari di Pomigliano d’Arco (NA). Vincenzo (1794/1873)
fu uno famoso botanico e padre dell’on. prof. Giuseppe Semola, e Mariano
fu ordinario di filosofia c/o l’Università di Napoli. Ai Semola ad
Ercolano e Napoli sono dedicate alcune strade.
Tale termine, invece, è di
origine nostrana, proprio di Torre del Greco. "E’ cotto... e ricuotto... cavere e cuotto... summulelle", "Cheste overo coceno...
summulelle", "Chi vvo ’a summulella...", queste, e forse
altre di difficile memoria, erano le "voices" dei venditori
ambulanti, fra cui molti ragazzi provenienti dalla zona mare, che
"sponsorizzavano" e vendevano la "summulella",
classica e gustosa pagnottella di farina di grano duro e semola o
semolino (grano duro o semiduro macinato), da cui il tradizionale nome. Tra i
primi venditori nella nostra città fu un certo Giovanni Di Donna, detto
"Giuvanni ’i Ronna", dai più ricordato come l’inventore
della "summulella", tipico prodotto torrese, in quanto, come affermano
i più anziani della zona, non v’è reale riscontro in altri paesi e
città italiane.
"Giuvanni" fu il capostipite fornaio con locale
in Largo Costantinopoli n. 3 (attuale antiquariato di mobili antichi D’Orlando),
il quale viveva con i suoi a fianco (farmacia Vetromile) al civico 5 ed in
seguito al civico 9 (ex salumeria di Tobia Tarantino).
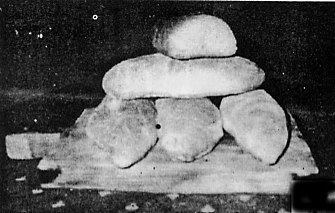
Tutti
in famiglia davano una mano nella bottega-forno, fra cui la nuora,
detta "Luisella", la quale negli anni delle famose tessere
annonarie, comprava la farina "fuori tessera" per la
fabbricazione del pane che in un batter d’occhio si vendeva alla gente,
costretta il più delle volte, a lunghe file all’esterno del forno, e
il figlio Salvatore (1874/1949, nonno del compianto don Salvatore
Maglione, parroco di Santa Maria del Principio) che, a sua volta, aprì un
forno-salumeria al I° vico Cappuccini n. 9 (al presente lavanderia "Rex"),
i cui unici ideali furono il lavoro inesausto e l’affetto per la
famiglia.
Il fedele continuatore della "summulella" fu l’altro
figlio, Angelo, ricordato come "’U marchese", autodefinitosi
successivamente "’U marchese ’dda Summulella".
Era un tipo snob e frequentava la nobiltà. Era solito recarsi al
"Gran Caffè Palumbo" (vicino la villa comunale), nei migliori
ristoranti locali, fra cui il mitico "Mimì a mare", l’albergo
"Santa Teresa" ed il teatro "San Carlo" a Napoli. Era
ben voluto e rispettato; era anche "nobile de coeur"; persona
generosa, inventiva, ambiziosa ed autocompiaciuta; facilmente comunicava
con gli altri, mai impulsivo, ben riusciva a fare da paciere tra la gente. Coniugato con una certa Luisa ("Luisella") che lo
aiutava "rint ’a puteca"; non ebbero figli. Titolare di una
"corallina" adibita alla pesca del corallo.
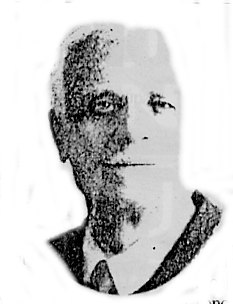

Capitò che una volta fu
invitato ad una cerimonia nel salone dell’albergo "Santa
Teresa" al Miglio d’Oro; molti gli ospiti di sangue blu che si
dilettavano fra canti, balli e ristori vari. Accadde
che un nobile (principe) in una accesa "discussione" esternò
parole offensive ad una signora, ospite della riuscita festa. A sua
difesa, fra la sorpresa dei partecipanti, intervenne Angelo, il quale alla
incalzante richiesta del principe: "Ma lei chi e?", rispose:
"Io sono il marchese della Summulella"...
Fuori il negozio a
Largo Costantinopoli vi era un giardino con un grosso albero di fichi
che iniziava dall’angolo di via Comizi, recintato da un muro;
poi, attraverso, scale in muratura, si accedeva alla pescheria comunale;
prima della pescheria, si trovava il portone d’ingresso della Caserma
dei Regi Carabinieri (poi Istituto Nautico ed Ufficio Tecnico Comunale),
al cui interno si trovava una grande grotta che fungeva da ricovero
antiaereo sotterraneo, comunicante con un tratto di via Comizi.
Dopo l’armistizio,
molti torresi del luogo vi trovarono rifugio, rimanendovi ben nascosti dai
rastrellamenti dei soldati tedeschi; quelli che furono presi e condotti su
camion, parcheggiati in piazza Santa Croce, ebbero come destinazione, dopo
un convogliamento, Maddaloni (CE), campi di prigionia e lavoro in
Germania. Dalla cittadina casertana, tanti nostri concittadini riuscirono
a scappare e tornare a casa... Poi vennero gli alleati che portarono un po’
di benessere; ma come il copione di allora richiedeva (la fame era tanta!)
ci furono assalti a mezzi militari che erano carichi di ogni ben di Dio...

Nel
1941 il forno, ubicato "'Mmiez ’a Santa Maria" (dal nome
dell’antica chiesa di S. Maria di Costantinopoli, da qualche anno
ristrutturata come la piazza antistante ed alcuni vetusti fabbricati) fu
venduto ai Tarantino (storica famiglia di panificatori e salumieri) che
seguitarono a produrre queste saporite e soffici "vascuttelle"
di farina di grano duro e sfarinato di "saragolla", e dal
colore variante fra il biondo ed il rossiccio. Esse definite anche il pane
dei poveri (unitamente al panino con la sugna), si possono distinguere in
"molle" (soffici) e "ammazzarute" (non lievitate
sufficientemente). Frequente era la vendita con lunghe file di persone,
provenienti anche da fuori Torre. Esse si possono gustare con la "nzogna"
(sugna), sale e pepe, quando sono croccanti e bollenti; con le alici
salate imbevute in ottimo olio d’oliva; con il tonno all’olio e con il
tonno e pancetta, leggermente pepata...ed innaffiata con un buon bicchiere
di vino o birra.
Altri leggendari e famosi panificatori, oltre ai Tarantino, sono stati: Biagio Mennella, detto "Biasiello ’u furnaro"
in via Piscopia (attuale salumeria al civico 58), Vincenzo Frulio, detto
"Papariello" (poi il figlio Vincenzo, 1933/1993), coniugato con
Angelina Balbi ("'Ngiulina ’a panettera", titolare di forno
e salumeria a Largo Bandito) con la quale si trasferì in via Teatro n. 39
(attuale panificio e prodotti alimentari, gestito dal nipote Francesco), i
f.lli Garofalo ("’Ndulino", "Vartummeo", Ciro, ecc.,
poi i figli ed i nipoti), Ciro Carrieri ("Fasolo") in via XX
Settembre angolo Vico Bufale, Raimondo Savastano ("’U taianese",
1923/1986, originario di Ottaviano (NA) con locale in via XX Settembre e
forno in via Agostinella; oggi "Il forno" è gestito dal figlio
Antonio), Francesco Maglione con forno alla 2^ traversa S. Noto n. 11
(antico forno dal 1896); i Mennella, i Raiola ("I mancini"), i
De Luca, Pasquale Brancaccio "Il fornaio" in via Calabria n. 68,
e tanti, tanti altri...
Le
foto: Gruppo di classiche "summulelle"; Salvatore Di Donna, fu
Giovanni (1894-1949); Vincenzo Frulio ("Papariello"); Largo
Costantinopoli (sui luoghi di una volta) al presente (anno 2000).