Scout
a Torre del Greco
di Peppe d’Urzo
Quarantanni fa e precisamente il 4 novembre 1966
(festività di S. Carlo e Commemorazione delle Forze Armate) alle ore
3,00, a Firenze, una spaventosa alluvione devasta la città. Il fiume Arno
invade il centro storico ed altri quartieri; le acque arrivano a 5 metri
d’altezza. In città si contano 35 morti, 6000 negozi e 12000 auto vanno
distrutti; scantinati e primi piani allagati; fango dappertutto ed
indurito velocemente. L’esercito interviene con distribuzione di viveri;
mancano acqua ed energia elettrica; i telefoni in tilt. Il dramma di
Firenze commuove; tanto forte è il fascino artistico della città medicea.
E mentre un po’ dovunque si raccolgono sottoscrizioni, la gioventù di
tutto il mondo si mobilita come ubbidendo a una parola d’ordine che
nessuno ha mai dato. Migliaia di giovani che furono definiti gli ”angeli
del fango” arrivarono, unitamente a famosi artisti, a Firenze e la loro
azione sarà fondamentale oltre che preziosissima per il recupero delle
numerose opere d’arte danneggiate.
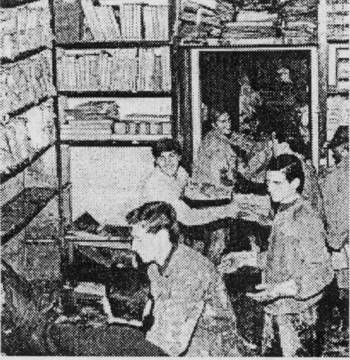
Essi si adoperarono a salvare la gente, i libri, le carte, scritti e tutto
ciò che sapeva di arte, alloggiando in strutture della Ferrovia dello
Stato, con cuccette adibite all’occorrenza. Anche Torre del Greco si
mobilitò in questo ”concours” di grande solidarietà
umana. Grazie al compianto prof. Antonio Ascione
(27.10.1924 – Torre del Greco – 18.01.1999), laureato in pedagogia,
insegnante alle elementari, magistrali, direttore didattico e presidente
del ”Gruppo 1° Scouts Torre del Greco” (con sede al Centro Sociale
dell’Ina Casa di via Circonvallazione), su autorizzazione del Ministero
degli Interni, si riuscì ad organizzare un contingente di 17 fra
”scouts” e ”Rover” per servizio volontario pro-alluvione, dal 26
al 31 dicembre 1966 (un altro contingente partirà in seguito). I giovani
”esploratori” torresi, con una piccola quota di partecipazione di
poche migliaia di lire, uniti ad altri gruppi del capoluogo campano,
partirono da piazza Dante a Napoli con tre pullman delle Forze
dell’Ordine; circa 150 elementi nel pieno della beata gioventù si
apprestavano a vivere una nuova esperienza di vita, mai dimenticata e
portata per sempre nel cuore.
Arrivo a Firenze in mattinata nei pressi del Battistero di Santa Croce,
coi terribili segni del fango impressi sulle porte d’ingresso, e,
quelle ”formelle” (riquadri con ornamenti di figure o intagli)
mancanti dal portone d’accesso del Duomo (col campanile di Giotto),
facevano una sensazionale impressione. I nostri piccoli eroi
cominciarono a spalare quella resistente fanghiglia accumulatisi nelle
cantine, negli scantinati e nei sottoscala di alcune abitazioni, fra cui
quella di un sacerdote a San Donnino (frazione di Firenze). Si lavorò
anche nei locali di una biblioteca (forse privata) a recuperare numerosi e
importanti libri. Si dormiva in un convento a Fiesole (comune attuali
15.056 ab. a 295 mt. s.l.m., su un colle dominante, con magnifico panorama,
la città di Firenze, da cui dista 6 km.) su di un freddo pavimento e con
le sole coperte, e, per tutti i giorni di permanenza con la sola divisa
con cappellone e giacche a vento per proteggersi dal freddo che cominciò
ad incalzare. Si desinava a mezzogiorno e sera presso l’Ataf (Azienda
tranviaria autonoma fiorentina).
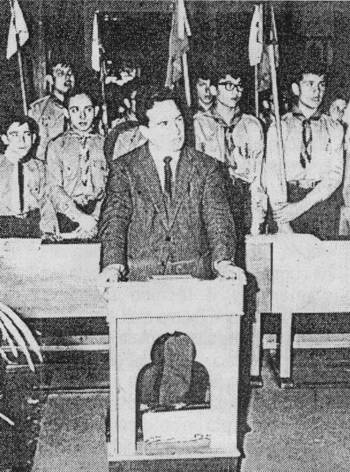
I boy scouts torresi portarono anche dei doni, preparati
nella nostra città, a dei bambini di una parrocchia in un’altra
frazione di Firenze. Il loro ausilio a favore degli alluvionati, in nome
di una grande solidarietà e situazione drammatica che rafforzò ed uni
tutti in una alta crescita collettiva, fu determinante. Fu un episodio che
segnò tutti ed una esperienza costruttiva. Quando ci si spostava da un
luogo ad un altro,
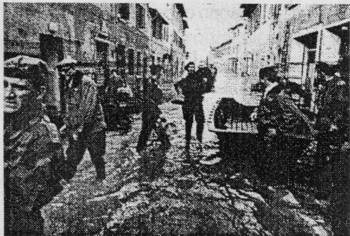
in una atmosfera autunnale con rara comparsa
di sole, erano evidenti i segni
del catastrofico disastro. I negozianti e commercianti cominciarono pian piano a
riprendersi, e, nelle vetrine ancora precarie di trasparenza,
cominciarono a vedersi i recuperati prodotti, che in precedenza facevano
bella mostra. In qualche bottega d’arte ricomparvero i pastori per i
presepi, esposti ancora col fango; fu un’attrattiva in più per
ricordare i giorni della straripante inondazione. Il contingente torrese
fece ritorno a Napoli e fu accolto festosamente dai familiari e
conoscenti; il fango era rimasto ancora appiccicato addosso ai nostri
ragazzi che, orgogliosi e felici per quel che avevano potuto fare, furono
ricevuti dal Card. Corrado Ursi nel Duomo che volle salutarli in un
caloroso abbraccio collettivo. Dopo ciò, il Governo Italiano si attivò
per porre le basi del
Ministero
della Protezione Civile (complesso delle strutture pubbliche destinate ad
intervenire in caso di calamità naturali; dal 1981 al 1993 ha fatto capo a
un apposito ministro senza portafoglio), e, quasi tutti i boy scouts
torresi (precursori e pionieri dell’attuale servizio di volontariato)
parteciparono ad un corso teorico-pratico coi Vigili del Fuoco, per due
anni consecutivi, presso alcuni stands della Mostra d’Oltremare a
Napoli. Qui si alternarono varie attività fra cui il lancio nel telo e
l’avvolgimento di manichette per l’acqua.
Fra gli istruttori si ricorda un valido ed esperto portiere, un certo
Persico. Ci fu, alla fine del corso, un’agevolazione governativa, per
accedere come ausiliario (servizio militare) nel Corpo dei Vigili del
Fuoco. Del primo contingente dell’Asci (Ass. Scoutistica Ital., poi
Agesci: Ass. Guide e Scouts Cattolici Italiani) di Torre del Greco che
prese parte alla ”missione” fiorentina si ricordano (e non ce ne
vogliano quelli non menzionati): Carlo Boccia, Enzo Balzano, Ciro
Ambrosino, Enzo Benigno, Luciano Sorrentino (da reparto ”G.ro Palomba”
con sede nell’Oratorio ”Beato Vincenzo Romano” in via V. Veneto), S.re Iovane, Andrea Borrelli, Gigino De Luise (detto ”II piccoletto”,
capo responsabile), Eduardo Barlassini, Leonardo Gaglione, S.re Polese,
ecc.

La loro bella uniforme era così composta: cappello color Kaki (tipo
guardia canadese), foulard bleu con bordo rosso, camicia (tipo militare) e
pantaloncino Kaki, calzettoni bleu, scarponcini e stemma sulla manica
destra ”Campania Felix”. Un motivetto che fu cantato dagli scouts
italiani e torresi nel dopoguerra l’Associazione fu soppressa durante il ventennio così recitava:
”Col cappellone e un giglio d’or, sempre restiam esplorator... Se
l’Asci è sciolta, con voce alta cantiam insiem...”.
Da ricordare che lo scoutismo (”lupetti”, da 6 a 11 anni; ”Scouts”
da 12 a 17 anni e ”Rover” da 17 in poi) è un movimento sorto nel 1908
in Inghilterra, per iniziativa di Baden Powell (Robert Stephenson Smyth,
1857/1941, primo barone ed ex generale inglese) con lo scopo di riunire
gli adolescenti in una organizzazione capace di sviluppare l’educazione
fisica e morale, mediante campeggi, esercitazioni di carattere premilitare
(senza le armi usate dagli eserciti), ecc. In Italia il movimento sorse
nel 1912. Proibito sotto il fascismo, risorse dopo la seconda guerra
mondiale, con caratteristiche eminentemente cattoliche.

A
Torre si formò anche un reparto nautico (o marino) con sede vicino la
chiesa di S. Maria del Principio (Sant’Anna), dedicato alla memoria di
Geppino D’Amato, guardiamarina, deceduto nell’ultimo conflitto
mondiale con medaglia al valor militare.
Un onorevole omaggio era dovuto
ai nostri ragazzi di allora che si recarono al capezzale di una città
sconvolta da una devastante alluvione che coinvolse giovani provenienti da
ogni parte del mondo in una solidale lotta contro i tanti disagi che
Firenze subì. La grande mobilitazione che fu un’impresa estenuante
salvò il grandioso patrimonio artistico fiorentino.
Firenze non poteva
essere abbandonata a se stessa; il mondo aveva bisogno di Firenze.
Le foto: tre immagini dell’alluvione di Firenze (04.11.1966); il prof.A. Ascione con un gruppo di ”scouts” di allora; l’elmetto del corso scouts/V.d.F. con stemma metallico Asci e Gei (Giovani esploratori italiani).