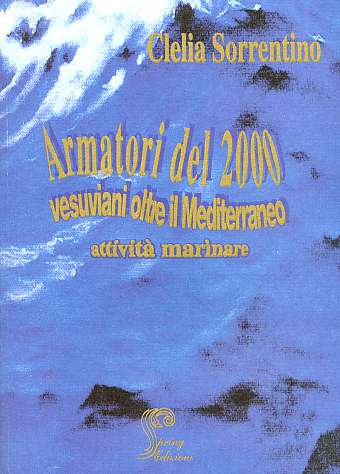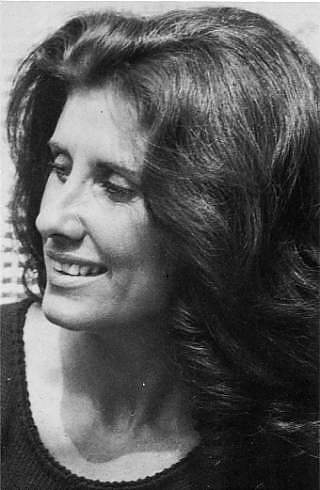|
La sezione Armatori torresi è
stata tratta dall'opera "Armatori del 2000"
Vesuviani oltre il Mediterraneo, una
delle ultime fatiche letterarie della scrittrice, per sua gentile concessione. Chi
volesse approfondire l'argomento, vastissimo, dettagliatamente descritto, si rivolga all'autrice.
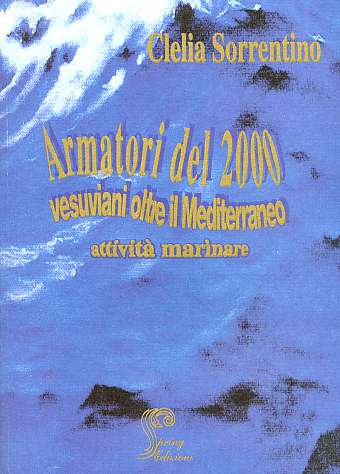
I miracoli
nascono dal mare
Premessa del Sindaco
Questa ultima fatica narrativa di Clelia Sorrentino
dedicata agli uomini di mare vesuviani e torresi in particolare mi
richiama alla memoria la scommessa di Gioacchino Murat.
Siamo nell’anno di grazia 1810 e Murat, re di Napoli, riceve il
rapporto annuale sull’economia del Regno. Bilanci e rendiconti non
sono proprio la sua passione. Lo deprimono. Lui sogna grandi imprese e
magari la conquista della Sicilia. Altro che note della lavandaia. Ma
tra i doveri di un capo di Stato, sovrano per volontà di Dio e di un
cognato imperatore, rientra anche quello di curare, nel bene come nel
male le sorti dei suoi sudditi. E cosi dando un’occhiata distratta ai
rendiconti che il Ministro Zurlo gli ha rifilato di buon mattino, il Re
esamina lo stato del Regno.
All’improvviso lo sguardo del Re si illumina e 1’occhio corre su
certi numeri. Sul suo volto si apre un sorriso, chiama il segretario
particolare e ordina: "Salpiamo per Torre del Greco, andiamo a
salutare i corallari! Perché?, accenna timidamente il segretario.
Perché ho vinto una scommessa e voglio festeggiare".
"La scommessa di Murat", una storia la cui veridicità si
fonda su una tradizione orale, e semplice. Riguarda, il corallo, il
mare, le barche i cantieri; 1’abilità dei torresi di pescarlo con
centonove barche e novecento uomini che avevano portato in porto
quartordicimila rotoli di corallo. Una potenza economica in grado di
colmare i buchi del bilancio statale con il solo incremento dell’intero
settore che alimentava cantieristica, armamento e pesca. Un comparto da
proteggere con defiscalizzazione e adeguata protezione.
Gioacchino Murat, aveva capito quale fosse il poderoso volano che i
torresi avevano attivato. Un gigante dell’economia in grado di
rianimare 1’intera economia del Regno.
Clelia Sorrentino riesce cosi a proporci, attraverso il sentire dei
protagonisti uno spaccato importante di quella scommessa di Gioacchino
Murat che costituisce una rivisitazione della storia della nostra città
e dei vesuviani del mare, facendo emergere il lato forte di questa
storia lunga di secoli. Storie diverse quelle raccontate ma tutte
riconducibili ad un concetto, per alcuni forse desueto, ma quanto mai
attuale. Ciò che emerge con forza, dall’ascolto dei protagonisti di
questo antico miracolo di queste nostre terre di mare, e la forza della
famiglia.
L’impresa che nasce, che si tramanda, che cresce, che affronta la
sfida del futuro con la forza di una salda tradizione.
Un testimone passato attraverso la capacita del nucleo familiare di
essere sempre coeso, pur se diversificato, pronto ad aprirsi a nuovi
orizzonti ma sempre poggiando e individuando nella famiglia la
"testata d’angolo", in grado di sorreggere ogni temperie.
E la storia di uomini, della loro capacita di aprirsi e di anticipare
nuovi orizzonti. Di credere nel futuro, avendo memoria del passato e
pronti a confrontarsi con il presente.
E questo il fascino della narrazione che Clelia Sorrentino ci propone,
facendo parlare i protagonisti di storie antiche che vengono da lontano
e che vanno verso il futuro. E il racconto di una sfida di generazioni,
e non tra generazioni. Sono sto- rie di uomini che sanno cosa sia il
mare. Storie affascinanti quanto semplici, senza retorica come si addice
a chi del mare ha fatto una ragione di vita. Sono racconti veri, di
uomini che hanno bandito ogni improvvisazione e ogni sorta di
dilettantismo, che hanno ed hanno avuto il gusto della sfida senza
avventura, con la consapevolezza di riferimenti inespugnabili radicati
nella certezza dell’unita familiare, certezza fondata sui valori, sui
sentimenti e giammai sulla forza economica. Nulla di romantico, nulla di
paternalistico. Nessuna storia di eroi, nessuna epopea, solo uno
spaccato di come nascono i miracoli dal mare.
Avv. Romeo Del Giudice
Sindaco di Torre del Greco
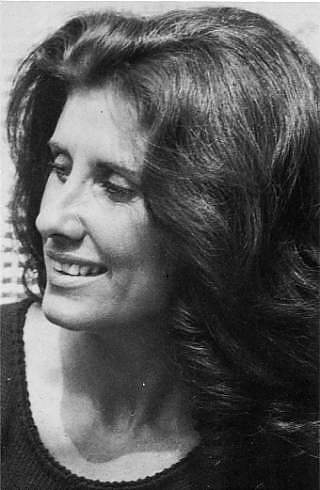
La scrittrice negli anni 80

Mostra estemporanea di pittura
organizzata dalla
Pro-Loco di Torre del Greco - 19 novembre 2000
La scrittrice porge una targa premio. |

La
scrittrice-giornalista Clelia Sorrentino
all'inizio della carriera
Premessa dell'autrice
Mediterraneo senza confini
COME NEL ’900
L’ARMAMENTO
VESUVIANO
HA ALLARGATO CONFINI
E MERCATI DEL "MARE NOSTRUM"
PARTONO I BASTIMENTI...
...Ppe’ terre assai luntane,/ cantan’ a buord’/ e so’
napulitan’, recita una nostalgica, antica canzone napoletana.
Bastimento, era termine generico usato per
denominare tanto il peschereccio che la spugnara, il veliero o la
corallina.
Armatore, per denominare colui che fa le spese per armare i
bastimenti da traffico e in genere li gestisce o li da in gestione per
ricavarne un utile.
La cognizione esatta di quanti e quali fossero e di quanti bastimenti
disponessero gli armatori vesuviani e torresi in particolare si perde
nel buio del tempo prima di fine ’800, quando rimbalzarono nella
cronaca per un fenomeno che fece epoca e usci dallo stretto ambito
locale per propagandarsi nel mondo e di cui parleremo appresso.
Si da per certo comunque che Giuseppe Mazza, il più importante ed anche
noto corallaro, possedesse un centinaio di coralline e che non fossero
da meno Aniello Mazza, Vincenzo Romano, Stefano e Michele Di Rosa.
Il che dimostra quanto da quei tempi i torresi vagheggiassero che un’intera
flotta di bastimenti partisse dalla loro città.
E’ anche accertato di quanto poi, mare e corallo, si intrecciassero di
fatto e nell’immaginario collettivo, come traspare dai versi composti
nel 1840 da Achille De Lauzieres e musicati da Francesco Florimo:
So’quattr’anne che partiste, /so’quattr’anne che 1’aspetto, me
lassaste, me diciste:/ nfra se ’ mise torno cca ’./ E da tanno, co
’ chist ’uocchie/ io spercianno sto lo
mare/ e addimanno ai marinare/ninno mio chi sa addo sta./ Me disciste
chillo juorno/mvaco a pesca a li coralle/de coralle, quando torno/ t’aggia
tutta com- miglia./Che sciucquaglie, e che mannizze;/che lazziette e che
collane,/ vedarraie quante sovrane/che t’avranno a media./Ah pecché
non si restato/Era ricca assai d’ammore,/ non c’e preta di valore/
che sto core po appassa. / Mo si tuorne, e ch ’io
so morta,/fa ’na croce de coralle/ e ala fossa de la morta /chella
croce aie da posa.
Nell’800, i corallari erano anche armatori e costruttori di propri
bastimenti (nel caso coralline), e la marina di Torre del Greco era un
alacre cantiere all’aperto ingombro di tronchi d’alberi e di uomini
che li segavano per ridurli in fasciame.
Nella zona denominata La Scarpetta in Portosalvo si costruiva
e si rifiniva febbrilmente persino negli androni dei palazzi quando non
c’era spazio sufficiente all’aperto.
A poca distanza, la nave, appena pronta, veniva fatta scivolare a mare e
il varo veniva benedetto nella chiesetta omonima di Portosalvo a via
Calastro (vedi foto della Marina torrese).
I vari avvenivano preferibilmente di domenica perché la tradizione
marittima e marinara era sentita visceralmente a Torre sicché la
popolazione nei giorni festivi poteva accorrervi. La curiosità era
grande e 1’affollamento oltre ogni limite.
Si pescava non solo corallo in Sicilia, fra Sciacca e Trapani.
In Sardegna e sulle coste nord-africane fervida era la pesca delle
spugne, soprattutto a Sfax. Veniva attuata con particolari bastimenti
chiamati spugnare, piuttosto tozzi e dalla carena piatta.
I cantieri torresi erano comunque rinomati per i normali
pescherecci-moto- pesca e per grossi gozzi adibiti al pescaggio di ogni
sorta di pesci di cui le coste mediterranee ed i loro anfratti
abbondavano. Secondo lo storico torrese Raffaele Raimondo, gih nel 1639
era stato fonda- to da padroni di coralline il Monte dei Marinai,
istituzione mutualistica laica, pur avendo sede nella chiesetta di S.
Maria Costantinopoli.
Oltre un secolo dopo, la Bolla della Crociata procacciava fondi
per la costru- zione di nuove navi (1778).
In tal guisa Ferdinando IV di Borbone si riprometteva di potenziare la
Marina Vesuviana a causa delle assillanti incursioni dei pirati
barbareschi che scorazzava- no nel Mediterraneo. Molte di queste navi,
qualche anno dopo vendute all’estero, furono costruite nei cantieri di
Castellammare di Stabia.
Nel 1780, avendo appurato la bonta dei banchi nord africani, un
gruppetto di corallari golosi, approdarono e si rifugiarono
temporaneamente usando come base 1’isolotto disabitato di Kalite per
razziare i nuovi, floridi banchi scoperti.
Essi vivacchiarono in quella landa assolata un bel po’ lontano dalle
famiglie e subendo moltissimi disagi.
Per quanto riguarda gli assedi corsari, pare che per combatterli alla
pari, i tor- resi dovettero anch’essi tirar fuori i propri denti
pirateschi, ma qui non si sa dove cominci la storia e dove finisca la
leggenda (vedi Pirati e Corsari: L’avventura di Capitano Accardo
di Catello Vanacore). Quel che e appurato tramite la lettura di un
introvabile libriccino del Cap. Mario Taddei: Armatori, risalente
alla prima meta del ’900 per Cavallotti Editore, e che * nuovi nomi
di quel periodo continuano a vivere, come rievocazioni di quel- la che
viene sommariamente considerata una marina partenopea. Della penisola
sorrentina restano i nomi di Grandi Famiglie: Astarita, Cacace, Cafiero,
Castellano, Ciampa, D’Esposito, Lauro, Longobardo, Maresca, PoIlio,
Romano, Russo, Savarese, Starita, Trapani. A Torre del Greco: Albanese,
Bottiglieri, CameIia, D’Amato, Del Gatto, lacomino, Lofaro, Loffredo,
Palomba, Perna, Di Maio. Di Vietri sul mare: Francesco della Monica. Di
Procida: D’Abundo, Mazzella, Attanasio. |